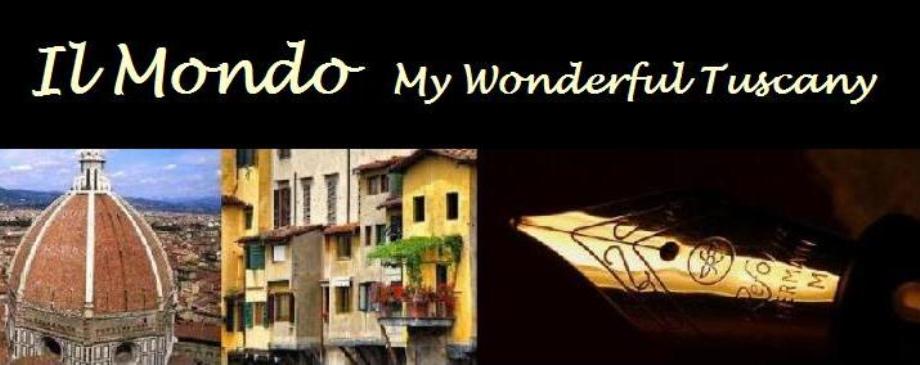Per gentile concessione di Simona Bellocci e facciunsalto.it
Casa di mia nonna si trovava ad appena trenta, quaranta metri dalla mia. Si affacciava su una piazza dove sembrava esserci racchiuso tutto il mondo o almeno ciò che bastava. Una città in miniatura. C’erano un bar, una chiesa, una scuola e un negozio di dischi. Era la fine degli anni Ottanta. Imperversavano Madonna, gli Wham, Europe, Duran Duran, A-Ah, Spandau Ballet, U2, Cindy Lauper e Bryan Adams. Ogni ragazzina aveva in camera, appeso al muro, un poster di Joey Tempest o di Simon Le Bon trovato su “Cioè” e soprattutto aveva l’ultimo 33 giri del suo gruppo preferito, da mettere su un piatto nei pomeriggi liberi dalla scuola. Per molte era così, per me non proprio. Certo, come ogni adolescente che si rispetti ascoltavo tutto quello che era di moda, ma amavo ancora di più la musica italiana. Grazie a mia zia Monica, che aveva appena dieci anni più di me, adorava i cantautori e più che una zia era una sorella. Non so quante puntine del giradischi abbiamo fuso in quegli anni, cantando come pazze distese sul tappeto del salotto. Il vinile gracchiava, consumato dalla nostra fame di musica. De Gregori, Vecchioni, Venditti, Battisti. Renato Zero non mancava mai. E poi “Firenze” di Ivan Graziani, nei giorni in cui eravamo malinconiche. Abbiamo ascoltato “Teorema” di Ferradini quando le pene d’amore si facevano sentire. “Luna” di Gianni Togni, quando fuori c’erano le stelle, d’estate.
I duetti, poi, ci entusiasmavano. Io, non so perché, dovevo sempre fare la parte dell’uomo. Così passavamo i pomeriggi a cantare “Buonasera dottore”. Mia zia faceva Claudia Mori, io Alberto Lupo. Non ne ero poi così entusiasta a dire il vero. Il bello però arrivava quando Monica metteva su il long playing con il rock’n roll. Eh beh, ballavamo scatenate. Sembrava di essere in un film. Ovviamente, tutto questo, quando la casa era libera.
Mio nonno, la domenica, cantava con la Vanoni “Domani è un altro giorno”. Faceva una giravolta e poi guardava fuori dalla finestra. Noi aspettavamo che ci lasciasse libero il salotto per mettere il 45 giri con la sigla di Happy Days.
Poi c’erano le canzoni nuove, quelle che sentivi passare alla radio ed erano bellissime. Spesso, quasi sempre a dire il vero, non ne conoscevamo il titolo. Ci rimaneva in testa però quel motivetto, il ritornello. Monica mi imponeva di scendere velocemente le scale, aprire il portone, correre verso il negozio di dischi e cantare al proprietario del Music Center quel refrain.
Questo era il patto tra noi, lei pagava l’album, io avevo il compito di individuare quale fosse il disco che si nascondeva dietro quel motivetto che passava la radio. E poi comprarlo. Così, vergognandomi come una ladra, provavo a recitarlo, invece di cantarlo al proprietario del negozio. A volte, commosso da tanto impegno e volendosi risparmiare il mio siparietto, mi indicava il settore delle novità. “Guarda, magari lì lo trovi”. Poi, gentilmente, mi faceva ascoltare il brano, per riconoscerlo. Dentro quel negozio così piccolo mi perdevo felice. Mi piacevano le copertine dei dischi, sopratutto quelle degli album. Quelli doppi, poi, erano fantastici. Con le foto e i testi.

Qualche giorno fa ho incontrato lui, l’uomo del negozio. Ha uno store Tim nel centro di Firenze, a due passi dal Duomo. Ci siamo riconosciuti. Ha ricordato le mie cantate, il mio amore spropositato per Barbarossa alle elementari e poi Carboni, con Silvia lo sai, alle medie. Ha sorriso, con l’immancabile foulard al collo. “Erano bei tempi”, abbiamo commentato. C’era un altro rapporto con le persone. E poi, la musica. All’epoca non c’era Shazam a trovarti in due secondi la canzone. Non avevi la app sull’Iphone che premi su un tasto, canticchi un po’ e ti ritrovi l’mp3 in tasca e pure il collegamento all’Apple Store per scaricare il brano e ascoltartelo in ogni momento. Non c’era neppure YouTube per vedere e sentire tutto quello che vuoi, quando vuoi, senza troppi problemi di sorta. All’epoca invece (oddio sembra che stia parlando dell’anteguerra) avevamo la radio, il mangianastri con il dito premuto sul “record” che appena passavano la canzone che ti piaceva così tanto dovevi essere veloce a beccarla dall’inizio, magari senza la voce dello speaker che l’annunciava.
La radio. Gran bella cosa. Quella c’è ancora ma è diversa. Monopolio delle case discografiche. Sempre gli stessi brani. Un martellamento, insomma. E invece era così bello accenderla e piazzarsi sull’FM, magari in auto. Emozionarsi, quando sentivi quella canzone che non ascoltavi da tempo. Ti passava davanti un ricordo. Un’immagine, un pezzo di vita. Le cose si gustavano di più, proprio perché non avevi tutto a portata di mano. Non avevi tutto il mondo nel cellulare. Dicono che sia un bene. Forse. Io l’Iphone ce l’ho. E pure l’Ipad. E il Mac Air, per fare tris, che non sia mai che qualcosa ci manchi, in questa vita. Però non so se apprezzo tutto ciò che ho. Non so se ne riconosco il valore. Così mi prende un po’ di malinconia quando ripenso a mia zia, ai pomeriggi tra il tappeto e il divano, a cambiare dischi su dischi. Alle canzoni alla radio. Quando il tempo non sapevo che fosse un valore, ora che passo la vita la correre, rubando minuti a me stessa.
E’ un po’ come quando mio padre ci racconta di quando era piccolo, un bambino nato dopo la guerra. Dice sempre che la carne la mangiava una volta al mese. Mia madre invece, figlia di ricchi commercianti, non ci crede. Non ci ha mai creduto a questa storia. Chi ha, non sa.
E’ domenica. Metto su un 45 giri. Anni Sessanta però. Gracchia tantissimo. Si incanta. Salta. Riparte. Questa è la bellezza. Il fascino dell’imperfezione. Delle cose che invecchiano. E che vivono anche fuori da quella modernità che dicono ci renda migliori. Io canticchio. Cancello Shazam dalle App. Non voglio il mondo in una mano. Mi basta anche meno.